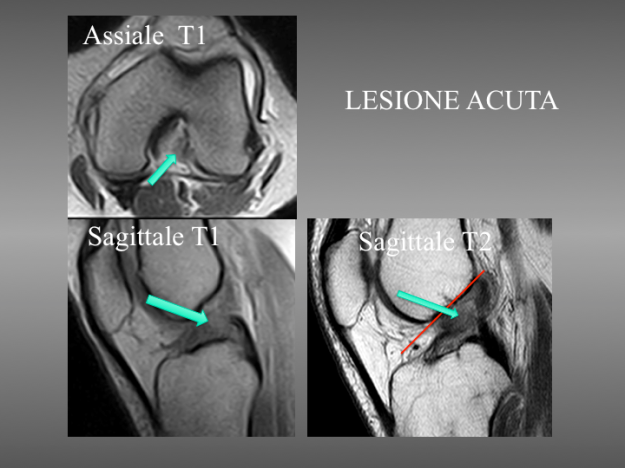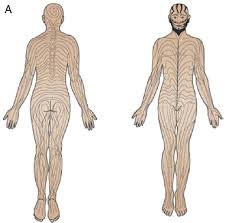Non sono riuscita finora a pronunciarmi sulla questione Weinstein e sulla questione, soprattutto, Asia Argento, perché mi sento molto piccola e inutile davanti a queste tematiche e perché, di base, ho già parecchi motivi di stress nella vita.
Quindi mi sono limitata a leggere, rileggere, sudare, leggere ancora, rimanere sbigottita, ascoltare, sudare nuovamente. Finora. Adesso, per chi c’è , per chi vuole, per me, umilmente dico la mia basandomi solo su quelle che sono le mie esperienze di ragazza molto fortunata e mai, graziaddio, stuprata.
Non faccio qui un sunto della questione, delle denunce di Paltrow, Jolie, Argento, McGowan, perché se avete google sarete più bravi di me a saperne moltissimo. Partirò dal mio breve curriculum di molestie, che si basa fondamentalmente su due cardini:
CARDINE UNO
Quando avevo 18 anni andavo in piscina. Per accedere alla piscina, sotterranea, si doveva fare una scala a chiocciola isolata. Un giorno un tizio ha cominciato a seguirmi dal parcheggio fuori dalla piscina con un rosario di “sei bella”, “mi piaci”, “vieni con me” che mi hanno spaventato un po’ e mi hanno convinta ad accellerare verso la scala a chiocciola. Errore, dovevo fare dietro front. Il ragazzo mi ha seguita e una volta dentro l’edificio mi ha detto “vieni in bagno con me” mi ha preso per un polso, mi ha tirata, io ho puntato i piedi ed ho fatto una cosa inaspettata: ho cominciato a lanciare delle urla non umane, da animale al macello, che hanno fatto sobbalzare il tizio. Io sono corsa via, appena in tempo per sentirlo urlare: “Ti guardo dalle vetrate!”.
In costume, in preda al vomito, mi sono affacciata dalla piscina e lui era lì, oltre i vetri. Sono tornata indietro, ho chiamato mio padre e mi sono fatta venire a prendere.
Fine.
Portavo una minigonna, e non sono riuscita a pensare ad altro per molti giorni seguenti. Questa storia non la conosce praticamente nessuno, e io non me la ricordo, devo dire, come un forte trauma, quantomeno a livello conscio.
CARDINE DUE
Ho avuto la squisita possibilità di lavorare, nella mia vita, per un maiale seriale. Era uno a cui piacevano le donne come a me piacciono i pop corn, e io non mi sento in colpa quando fagocito un pop corn con golosa arroganza. Io davanti ai pop corn proprio non riesco a controllarmi.
Non so se ho reso l’idea.
Si trattava di un tipo che una volta nell’atto di pagarmi il compenso settimanale mi ha detto “tieni, con questi ci compri le mutandine col pizzo”, che si era fatto l’idea di avermi non assunto bensì comprato, e che un giorno decise che era una buona idea infilarmi una mano tra le gambe, per vedersela piroettare nell’aere un secondo dopo. In quella circostanza concluse la questione con: “Un po’ alla volta ti abitui”. Non ho avuto motivo di abituarmi, l’ho spinto via, per me da allora è un poveretto e basta. Nulla di più. Me ne sono andata prima, ma no, non ho fatto casino, non gli ho tirato una sberla, ho continuato a lavorare. Volevo i miei soldi, mi servivano. Ero brava in quel fottuto lavoro. Me li meritavo i soldi che guadagnavo, e forse non me li avrebbe dati se non fossi stata zitta. Avevo 22 anni, probabilmente oggi avrei reagito diversamente. Oggi, protetta dalla maturità, da una forza moltiplicata, forse avrei reagito facendo un casino così.
Forse.
Come credo sia ora chiaro, sono una ragazza fortunata. Non sono finita violentata in un bagno, né sul posto di lavoro. E questo lo abbiamo stabilito. Ora, consapevoli io e tutti del punto di partenza da cui mi avvio, darò la mia risposta ad alcune delle affermazioni idiote che ho letto sulla questione Weinstein.
“Perché denunciare adesso, e non 20 anni fa?”
Davvero. Sfugge anche a me. Perché denunciare ora che ho 40 anni, sono un’attrice conosciuta in tutto il mondo, la mia carriera è ormai marmorea e intoccabile, ho una famiglia, magari un marito o un compagno che lotta al mio fianco, sono cresciuta, psicologicamente pronta?
Perché cavolo non l’ho fatto quando avevo 20 anni, non capivo moltissimo della vita, dovevo ancora costruirmi una carriera, non mi conosceva ancora nessuno?
Cielo, sono proprio un’idiota!
“Alcune hanno detto di NO ed hanno rinunciato a un carriera, quindi si può dire di NO”
È vero, ed è fantastico. Dico davvero: Forse ora tutti saprebbero chi è Tippi Hedren, se avesse detto di sì al buon Alfred. Chi decide per salvaguardare la propria dignità (parola che mi pare piaccia tantissimo usare, in questi giorni, da molti che sembrano aver capito tutto dalla vita). Chi è riuscito a denunciare subito o almeno ci ha provato, ad avere giustizia, come Ambra Battilana Gutierrez, merita elogi e rispetto.
Sopresa: lo meritano anche le altre. Quello che forse non è chiaro, è che a 20 anni (ma anche dopo talvolta) non è affatto chiaro a tutte che la dignità è la cosa più preziosa che hai, Forse la stima che hai di te (sì, anche se sei Angelina Jolie) non è così alta come può apparire dall’esterno. Forse vuoi salvarti il culo, il lavoro, e soprattutto, forse non hai le spalle per sopportare gente che fa affermazioni stupide come: “E tu…ci sei andata quindi nella sua stanza…quindi lo sapevi, no?”.
Forse, se capita a me, non penso che sia vero. Forse penso che apparirei folle e accusatoria se dicessi al mio capo “no, non voglio rimanere in una stanza da sola con te“. Forse sono nel panico e sto pensando “Beh, se proprio dovesse fare qualcosa di stupido io urlo e sono salva, no?”. Forse in camera sua mi ci accompagna una donna e allora penso “se mi ci accompagna lei, sono in una botte di ferro”.
Non so queste cose con certezza, io non c’ero quando è accaduto. E, pensate un po’, non c’eravate neanche voi che la sapete tanto lunga.
“Hanno padri e famiglie famose, erano protette a Hollywood”
E dai rubinetti scende il miele. Certo, se tuo papà è uno famoso tu non hai paura di niente, non ti incolpi di niente, la tua giovinezza è un tagada di gioia e allegria, non vai in depressione, non ti droghi, è tutto bellissimo.
Lasciate che vi faccia un elenco dei pensieri che, per quella che è la mia esperienza, potrebbero venirti se qualcuno ti mette le mani addosso, e nessuno vi ha visti mentre accadeva:
“Cosa ci siamo detti prima?” “IO cosa ho detto?” “Ho il corpo e la faccia di una con cui puoi farlo?” “Le persone in me vedono questo? Tutte? Vogliono molestarmi tutti quanti?” “Non mi crederà nessuno” “Mi rovinerà la vita” “Se lo faccio arrabbiare la prossima volta non si ferma e mi violenta di sicuro” “Sto perdendo tutto” “Non posso dirlo a nessuno” “Ci sono andata io in quella camera” “Fermati” “Se urlo qualcuno mi salverà e io sarò la cogliona troia che prima è entrata qui con lui e poi dice di no e la mia vita sarà rovinata anche se non mi stupra”
La tua amorevole famiglia, i tuoi amici comprensivi, la tua adorata sorella che ti protegge sempre, i soldi, la fama, il tuo talento, quanto sei fantastica; niente di tutto questo ti verrà in mente in quel momento. Non servirà e non servirà neanche dopo che è successo, a meno che tu sia abbastanza forte da concentrarti su tutte queste cose.
Ci sono donne, e ragazze, meravigliose. Eroine incommensurabili, come la ragazzina che è stata violentata sugli scogli a Marechiaro, costretta a sentirsi dare della puttana per mesi prima che due testimoni confermassero che era stata vittima di uno stupro di gruppo. Ha denunciato tutto, li ha stanati su facebook, li ha costretti a venire allo scoperto, è sopravvissuta alla gogna dei social. Ed ha vinto. Lei è per me una vera eroina, ripeto.
E poi ci sono quelle che non denunciano, che non ce la fanno, che non resistono e diventano degne di attenzione, per voi, solo se al culmine del dolore si lanciano dal cavalcavia o si appendono a un albero con una corda. O se non sono Asia Argento, che nei film fa cose sconce quindi, è ovvio, tende a farle anche nella vita (ma siamo seri? Quindi le attrici porno le sodomizziamo tutte “perché sì”? Perché ho letto anche insinuazioni di questo tipo).
“Asia Argento non lo ha fermato mentre subiva un rapporto orale, ha detto che gli avrebbe rovinato la carriera”
Forse gliel’ avrebbe rovinata, forse no. Ma questo, lei, a 20 anni non poteva saperlo. E c’era uno alto più di lei, pesante più di lei, infoiato MILLE VOLTE più di lei (che ha spiegato che era infoiata a livello ZERO) che le ha aperto le gambe. E fine.
Questa cosa, se accade (ebbene sì, anche se tuo padre è UNO-FA-MO-SO) ti rimbomba nel cervello, con tutto il carico di sensi di colpa che si creano. Non occorre essere fini psicologi per sapere che dietro a molte molestie c’è una vittima che si chiede: “Sono io, in quanto me, la causa di queste molestie?”
“Ha avuto con lui una relazione lunga 5 anni quindi ci è stata quando le serviva”
Io capisco che leggere gli articoli in lingua originale non sia un dovere, ma se poi vogliamo disquisire di cose importanti è bene cominciare ad informarsi. Asia Argento non dice al New Yorker che Weinstein è stato il suo fidanzato per 5 anni. Parla di episodi sporadici, “univoci e platonici” e dà una spiegazione, condivisibile o meno, per ognuno di essi. Se vogliamo criticare la sua posizione, prima potrebbe essere utile capire quale essa, esattamente, sia.
E, cosa quantomeno interessante, spiega: “Ogni volta che me lo ritrovo davanti, sono sempre la ragazzina di 20 anni, sola, in balia di quell’uomo”. È vero, è esattamente così che può accadere. È uno scacco matto mentale al quale non ci piace credere, perché significa che sotto sotto non si è mai abbastanza forti, sotto sotto l’angoscia è come un conato di vomito, disgustoso e inaspettato. Dura un attimo ma c’è.
Forse tutte le donne che hanno denunciato Weinstein mentono. Chissà. Chi può dirlo. Io non ero lì. È per questo che esistono le indagini, i tribunali e roba del genere: perché sono loro, a stabilire certe cose, sulla base di fatti, si spera. Non tutti gli altri.
“È troppo comodo parlare ora”
No, davvero. Adesso qualcuno mi venga a dire che si trae qualche vantaggio a dire non “mi ha legata a un muro, mi ha imbavagliata, mi ha messa nel retro di un furgone, mi ha portata nel bosco e mi ha violentata” MA“Mi sono fidata, non sapevo, non sono riuscita a reagire, mi ha bloccata, avevo paura, mi sentivo di perdere tutto, non sapevo che fare”.
Sentirsi colpevoli quanto il colpevole. Ammettere un silenzio. Ammettere l’assenza di una reazione adeguata. Tutto questo nella coscienza che la gente potrebbe non capire (e infatti non ha capito).
Sapete cosa c’è di comodo? Avere 65 anni e tutti i soldi del mondo, così tanti che anche quando viene a galla che sono un molestatore seriale posso dire “Scusate, davvero, chiedo scusa a tutte le donne che ho fatto soffrire, devo pagare per questo, devo curarmi, sono malato”, ammettere tutto, partire per andare a fare riabilitazione in un centro da due fantamiliardi di dollari al giorno, perdere il lavoro (ma ho 65 anni, non 20, o 40) perdere la moglie, preservare i miei figli, vedere il mio nome sbiadirsi sui giornali perché l’inchiostro serve per quella che “è ambigua”, o per quella che “aveva i genitori a Hollywood” o quella che “poteva dire di no”.
E aspettare che il mondo dimentichi le mie porcate.
Questo, secondo me, è comodo.